Il concetto di “gli altri” (o “l’altro”, in senso più generale) ha radici profonde in filosofia, sociologia e psicologia, e rimanda a tutto ciò che è esterno all’io, alla mia soggettività. Parlare di “altri” significa riconoscere persone, comunità o entità che non coincidono con il “sé”, e con cui inevitabilmente ci relazioniamo. Questa relazione, a seconda del contesto, può assumere forme diverse: conflitto, cooperazione, empatia, rifiuto, comprensione, identificazione, estraneità.
Di seguito alcuni punti chiave per definire e analizzare il concetto di “gli altri”:
-
Distinzione tra “io” e “non-io”
- In senso basilare, “gli altri” sono coloro che si differenziano da me, il che presuppone un confine fra un “io” (o soggetto) e un “tu” (o oggetto esterno alla mia coscienza).
- Questa distinzione è alla base della consapevolezza soggettiva: prendiamo atto di noi stessi in quanto entità separate e autonome solo quando riconosciamo anche qualcosa (o qualcuno) di differente.
-
Dimensione sociologica
- Nel contesto sociologico, “gli altri” possono rappresentare un gruppo sociale diverso dal proprio, un “loro” a fronte di un “noi”. L’identità di un gruppo si definisce spesso in opposizione o in confronto con altre comunità, culture, minoranze o maggioranze.
- Concetti come “in-group” e “out-group” (gruppo di appartenenza e gruppo esterno) mostrano come la percezione che abbiamo di “chi è con noi” e “chi è diverso da noi” influenzi la nostra visione del mondo, la costruzione dei pregiudizi e la formazione di stereotipi.
-
Prospettiva filosofica (esistenzialismo e fenomenologia)
- Jean-Paul Sartre, in “L’essere e il nulla”, definisce “l’altro” come lo sguardo che mi rende oggetto. La celebre frase “l’inferno sono gli altri” (“L’enfer c’est les autres”) si riferisce alla frustrazione che deriva dal sentirsi costantemente visti e giudicati da sguardi che non posso controllare.
- Emmanuel Levinas, invece, pone l’altro al centro della sua etica, considerando l’incontro con l’altro come un’esperienza di responsabilità ineludibile: il volto dell’altro è un appello etico che mi chiede di rispondere, di prenderlo in considerazione. In questo senso, la relazione con l’altro diventa lo spazio in cui si fonda la moralità.
- Martin Buber, nel suo saggio “Io e Tu”, distingue tra la relazione Io-Tu (un incontro dialogico autentico) e Io-Esso (in cui l’altro è ridotto a oggetto). Nella relazione Io-Tu, l’altro è riconosciuto in quanto persona dotata di dignità e identità irripetibile, non come semplice entità da usare o da manipolare.
-
Prospettiva psicologica
- Dal punto di vista dello sviluppo individuale, la percezione degli altri (i primi “altri” sono i genitori, i familiari, poi gli amici, i conoscenti, ecc.) contribuisce a formare l’identità. Il bambino riconosce la propria soggettività confrontandosi con chiunque non sia sé stesso.
- L’empatia e la teoria della mente (cioè la capacità di comprendere che gli altri hanno pensieri, desideri, emozioni propri) dimostrano come il rapporto con l’altro sia fondato su un processo di “messa in prospettiva” del proprio punto di vista.
- In psicologia sociale, concetti come “conformismo” e “influenza sociale” mostrano come il giudizio, le norme o gli atteggiamenti degli altri incidano sul nostro comportamento e sulla nostra autopercezione.
-
Politica e differenza
- Nella dimensione politica, “gli altri” possono essere visti come risorsa (pluralità di prospettive) o come minaccia (quando percepiti come “estranei”, “diversi”, “ostili”). Queste rappresentazioni possono sfociare in inclusione o esclusione, riconoscimento o discriminazione.
- Il dibattito sull’alterità è cruciale per comprendere fenomeni come il razzismo, il sessismo, l’omofobia e in generale tutte le forme di discriminazione basate sul fatto che un gruppo (o individuo) è considerato “altro”, non appartenente alla comunità dominante.
-
Identità e alterità
- Non si può parlare di “io” senza “l’altro”: la formazione dell’identità dipende dal rapporto con ciò che è esterno. Attraverso l’alterità, comprendo i miei limiti, le mie diversità e ciò che mi rende unico.
- Al tempo stesso, l’altro non è mai completamente “altro”: l’esperienza condivisa di essere umani crea un terreno comune su cui possiamo comunicare, entrare in empatia, riconoscerci simili oltre che differenti.
-
Rischio di oggettivazione e strumentalizzazione
- Quando l’altro viene trattato come un oggetto, in termini meramente utilitaristici o stereotipati, si interrompe ogni possibilità di relazione autentica e rispettosa.
- Questo rischio è presente in diversi ambiti: dalle relazioni di potere (dominanti/dominati) all’economia (consumatori o lavoratori ridotti a numeri), fino ai rapporti interpersonali.
-
Dialogo e responsabilità
- Riconoscere “gli altri” come soggetti dotati di un proprio punto di vista, di una propria autonomia e sensibilità, implica un impegno etico. Il dialogo autentico, secondo molti filosofi, richiede apertura, volontà di comprensione e sospensione dei propri pregiudizi.
- Il “confronto con l’altro” è anche occasione di crescita: ascoltare e integrare prospettive diverse può arricchire l’individuo e la società nel suo insieme.
In sintesi, il concetto di “gli altri” non indica soltanto individui o gruppi differenti dal “me”, ma rappresenta la dimensione della relazione e della distanza tra soggetti. È un tema cardine per comprendere come costruiamo la nostra identità, come interpretiamo la realtà sociale e quali dinamiche si innescano nei rapporti interpersonali e collettivi. Dal confronto con ciò che è “altro” rispetto a me – sia in termini di differenze culturali, ideologiche o valoriali – nascono sfide ed opportunità: il rischio di chiusura e di conflitto, ma anche la possibilità di arricchimento, comprensione profonda e creazione di legami più autentici.

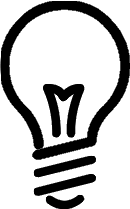 Gli altri
Gli altri
