 | Attendere prego... |
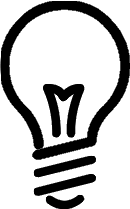 Relazionismo
Relazionismo

Il termine Relazionismo (talvolta usato come equivalente di “relazionalismo”) indica un orientamento filosofico, epistemologico o teorico secondo cui la realtà non è costituita primariamente da sostanze o entità autonome, ma dalle relazioni che intercorrono fra di esse. In altri termini, l’identità di un qualunque elemento — sia esso un oggetto, un evento o un individuo — è definita e acquisisce senso soltanto all’interno di una rete di relazioni.
Primato della relazione
L’idea centrale è che nulla esista in modo isolato: ogni fenomeno, processo o “cosa” va compreso a partire dalle sue connessioni con il resto del contesto. L’essenza non risiede quindi in una proprietà intrinseca e fissa, ma in un continuo intreccio di rapporti.
Costituzione dinamica dell’identità
Se l’identità deriva dalle relazioni, allora essa è per sua natura dinamica: quando cambiano le relazioni, cambia anche ciò che un’entità è. Questo vale sia per realtà fisiche (ad esempio in certi modelli di fisica o biologia), sia per realtà sociali o simboliche (relazioni tra persone, istituzioni, significati culturali).
Contrasto con l’ontologia “sostanzialista”
Il Relazionismo si oppone, almeno in parte, alle tradizioni filosofiche che concepiscono la realtà come formata da sostanze o essenze autonome, statiche e autosufficienti. Al posto di “oggetti” in sé, pone l’accento su reti, processi, influenze reciproche.
Applicazioni interdisciplinari
È importante non confondere Relazionismo con relativismo.
In sintesi, il Relazionismo invita a concepire il mondo — e la conoscenza che ne abbiamo — come una fitta trama di relazioni in continua evoluzione. Nulla esiste, né può essere compreso, fuori dal proprio contesto relazionale. Questo approccio trova applicazione in diverse discipline (filosofia, scienze sociali, scienze naturali, teologia) e permette di mettere a fuoco la dimensione interattiva, processuale e costitutivamente “aperta” della realtà.