 | Attendere prego... |
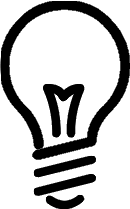 Funzionalismo
Funzionalismo

Il termine funzionalismo può riferirsi a diversi ambiti disciplinari – dall’architettura e dal design alla filosofia (in particolare la filosofia della mente), fino alle scienze sociali. In senso molto generale, il funzionalismo è un approccio che mette al centro la funzione (o lo scopo) di un oggetto, di una costruzione o di un fenomeno, ponendola come criterio essenziale per comprenderne o progettarne la forma e l’organizzazione.
Di seguito, analizziamo due accezioni significative del termine.
Nel campo dell’architettura e del design, il funzionalismo è un principio secondo cui la forma di un edificio o di un prodotto deve rispondere alle sue funzioni pratiche e agli scopi specifici per cui è stato realizzato. Il celebre motto attribuito all’architetto Louis Sullivan, “form follows function” (“la forma segue la funzione”), riassume l’idea che l’efficacia pratica e l’utilità siano prioritarie rispetto all’estetica o all’ornamento superfluo.
Fine XIX – inizio XX secolo: I precursori del funzionalismo, come lo stesso Louis Sullivan negli Stati Uniti e Adolf Loos in Europa, criticano la decorazione eccessiva e sostengono che l’architettura dovrebbe riflettere anzitutto i bisogni dell’uomo e le possibilità offerte dai nuovi materiali (acciaio, cemento armato, vetro).
Movimento moderno e Bauhaus: Nel corso del XX secolo, la scuola tedesca del Bauhaus (fondata da Walter Gropius) e architetti come Le Corbusier e Ludwig Mies van der Rohe sviluppano ulteriormente i principi funzionalisti. Da essi derivano anche concetti come la standardizzazione industriale e la riduzione delle forme all’essenziale.
Funzionalismo nordico: In Scandinavia, architetti come Alvar Aalto applicano il funzionalismo con un’attenzione particolare anche alla dimensione umana, all’ergonomia e ai materiali locali, sviluppando un approccio più “caldo” e attento al contesto.
Primato della funzione: la forma e la struttura di un oggetto o di un edificio sono governate da finalità pratiche (abitazione, lavoro, trasporto, ecc.).
Razionalità e semplificazione: l’idea che le soluzioni progettuali più “pulite” e lineari siano generalmente le più efficaci.
Onestà dei materiali: l’uso di materiali in modo coerente con le loro proprietà fisiche ed estetiche, evitando finzioni decorative.
Riduzione dell’ornamento: la bellezza scaturisce dall’equilibrio tra proporzioni, funzionalità, luce e spazio, più che da decorazioni superficiali.
Eccesso di razionalismo: Il funzionalismo viene talvolta criticato per la sua tendenza all’astrazione estrema, che potrebbe trascurare bisogni emotivi, simbolici o culturali.
Postmodernismo: A partire dagli anni Settanta, alcuni architetti e designer postmoderni rigettano la rigidità dei dettami funzionalisti, reintroducendo elementi ornamentali, simbolici o storicistici.
Design contemporaneo: Molti progettisti attuali coniugano i principi funzionalisti (utilità, ergonomia, sostenibilità) con una ricerca di nuovi linguaggi formali, tecnologie avanzate e un’attenzione all’esperienza complessiva dell’utente.
Nella filosofia della mente, il funzionalismo è una teoria secondo cui gli stati mentali non dipendono dalla materia o dalla “sostanza” del cervello, ma dalla funzione (o ruolo causale) che quegli stati svolgono all’interno di un sistema. In altre parole, un pensiero, una credenza o un dolore sono definiti dalla loro funzione (input, elaborazione, output), e non dal “supporto fisico” che li realizza.
Equivalenza multipla: uno stato mentale può essere realizzato in vari “substrati” fisici (cervello biologico, computer, eventuali intelligenze artificiali), purché la stessa funzione sia rispettata.
Analogia con la computazione: alcuni sostenitori del funzionalismo paragonano la mente umana a un software, mentre il cervello sarebbe l’hardware.
Ruolo causale: per identificare uno stato come “dolore”, ad esempio, bisogna considerare cosa lo causa, come influenza altri stati mentali e comportamenti, e che reazioni produce.
Qualia: i fenomeni soggettivi (“qualia”, come il “rossore” di un rosso) sono difficilmente riconducibili a meri ruoli funzionali.
Obiezioni “cinese room”: il famoso argomento di John Searle mette in dubbio l’idea che il semplice processamento di simboli equivalga a una vera comprensione o coscienza.
Il funzionalismo, in qualsiasi contesto, valorizza l’idea che la funzione o lo scopo di un oggetto (sia esso un edificio, un prodotto di design o un concetto mentale) debba essere determinante nel plasmarne la forma e la struttura. In architettura e design, si traduce in principi di semplicità, razionalità e coerenza costruttiva. In filosofia, implica la comprensione degli stati mentali in termini di ruoli causali, influenzando importanti dibattiti sulla natura della coscienza e dell’intelligenza artificiale.
Con il tempo, ogni branca ha elaborato varianti e correttivi a un funzionalismo troppo rigido, tenendo conto di fattori come l’emotività, la simbolicità, il contesto culturale e il valore estetico. Tuttavia, l’idea portante – che la funzione sia una chiave interpretativa primaria – rimane un concetto cruciale per comprendere tanto l’evoluzione del pensiero progettuale e architettonico, quanto le teorie della mente.