 | Attendere prego... |
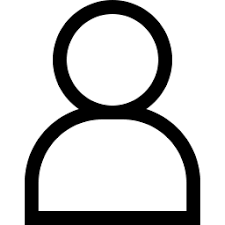 Simmel, Georg (1858 - 1918)
Simmel, Georg (1858 - 1918)

Georg Simmel (1858-1918) è stato un sociologo e filosofo tedesco considerato tra i padri fondatori della sociologia “formale”. Le sue opere hanno spaziato dalla filosofia alla sociologia, dall’estetica all’etica, offrendo un approccio originale all’analisi della vita sociale. Di seguito alcuni punti chiave del suo pensiero:
Georg Simmel ha aperto la strada a una concezione della sociologia come studio delle forme di interazione e dei processi di associazione. Attraverso le sue opere – dalla Filosofia del denaro al saggio sulla Metropoli – ha evidenziato come la modernità e la crescente differenziazione culturale incidano sulle relazioni sociali e sull’esperienza individuale. L’importanza attribuita alle dinamiche relazionali, alla soggettività e alla vita quotidiana fa di Simmel un pensatore ancora attuale e di fondamentale importanza per comprendere i fenomeni sociali contemporanei.


"La filosofia del denaro" (1900)
Una delle sue opere più celebri, esplora l'influenza del denaro sulle relazioni sociali e sulla cultura, introducendo concetti innovativi come la "reificazione" e il "valore oggettivo".
"Sociologia: indagine sulle forme di socializzazione" (1908)
Fondamentale per la sociologia moderna, analizza le forme e i modelli delle interazioni sociali, stabilendo le basi per lo studio delle strutture sociali.
"Le grandi città e la vita dell’intelletto" (1903)
Saggio breve ma influente in cui analizza gli effetti delle metropoli sulla psiche e sui comportamenti individuali, introducendo il concetto di "blasé attitude".
"Problemi fondamentali della filosofia" (1910)
Esamina le questioni centrali della filosofia, con un approccio interdisciplinare e critico.
"La moda" (1895)
Studio sociologico sull'industria della moda come espressione di individualismo e conformismo, anticipando molti dibattiti contemporanei.
"La tragedia della cultura" (1911)
Esplora il conflitto tra la cultura soggettiva (creatività individuale) e la cultura oggettiva (le strutture sociali e istituzionali).
"Filosofia della modernità" (1914)
Riflessione sullo spirito della modernità e sull'impatto delle trasformazioni economiche e sociali sulla vita quotidiana.
"Saggi di estetica" (1907)
Una raccolta di saggi che affrontano il ruolo dell'arte e della bellezza nella vita umana.
"Filosofia dell’amore" (1921, postuma)
Analisi delle dinamiche dell’amore, della sessualità e delle relazioni interpersonali in chiave sociologica e filosofica.
"Sociologia della religione" (1904)
Studio delle implicazioni sociali della religione, con attenzione alle sue funzioni simboliche e strutturali.